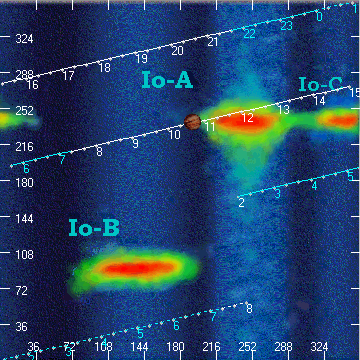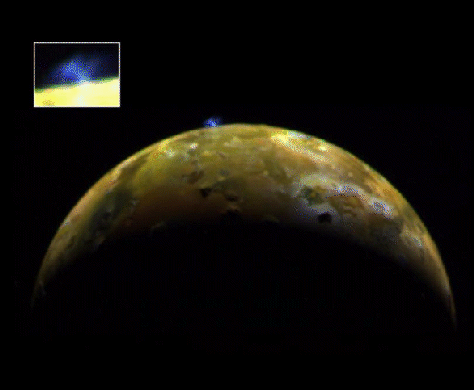Il prodotto dell'attivita' vulcanica
di Io, determinata da un surriscaldamento del cuore del corpo satellitare in
seguito alla forze di trazione che esso esercita in risposta alle sollecitazioni
gravitazionali, costituisce la fonte prevalente di SO2 per
l'atmosfera della piccola luna galileiana, accanto al processo di sublimazione
dell' anidride solforosa superficiale da uno stato semi-solido ad uno aeriforme.
Il biossido di zolfo in tal modo prodotto si deposita solo in parte al di sopra
della superficie del corpo satellitare; la relativamente debole attrazione
gravitazionale esercitata da Io permette infatti ai prodotti dell'eruzione di
fuoriuscire dal campo gravitazionale della luna galileiana, dal momento che la
loro velocita', in conseguenza alla violenza dell'espulsione, assume il piu' delle
volte valori maggiori ripetto al limite della seconda velocita' cosmica. Una
volta al di sopra dell' atmosfera di Io l' anidride solforosa, per effetto
fotochimico, si ionizza in cationi S+ ed O+ , andando ad costituire, assieme a
quantita' minori di Na, K, Cl, il cosiddetto toro di plama, una regione a forma
di "ciambella" orbitante attorno a Giove ad una distanza di circa sei volte il
raggio di quest' ultimo.
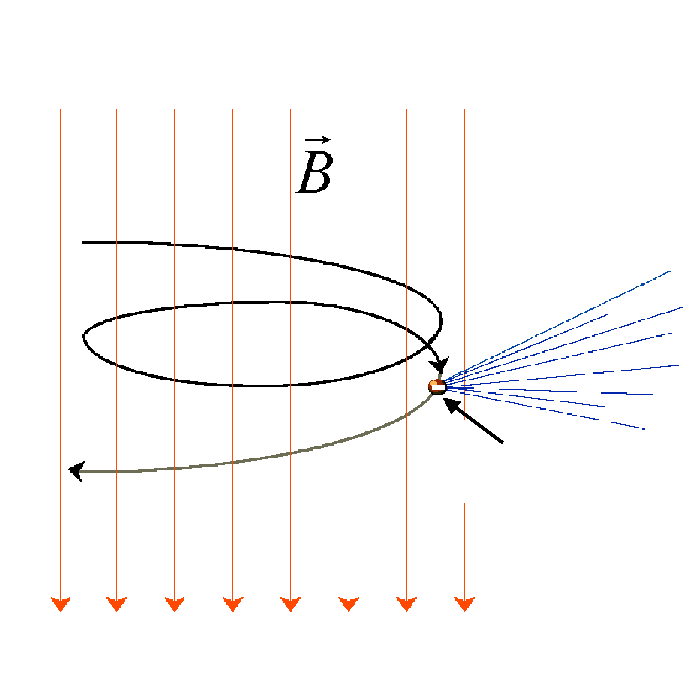 Il meccanismo di emissione e' un processo non
termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la
radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad
esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno
di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto
accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della
componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la
velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne
causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi
particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde
elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di
energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La
differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone
risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone
quand' essa assume valori relativistici.
Il meccanismo di emissione e' un processo non
termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la
radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad
esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno
di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto
accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della
componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la
velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne
causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi
particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde
elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di
energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La
differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone
risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone
quand' essa assume valori relativistici.
La radiazione prodotta per emissione
di ciclotrone si presenta polarizzata. L'orientamento complessivo dei fotoni liberati risulta distribuito
in una struttura conica il cui angolo di apertura puo' essere calcolato note le condizioni
iniziali del sistema radiativo. Una tipologia di emissione quale quella sopra
descritta permette quindi di giustificare il discontinuo manifestarsi dei
segnali gioviani. Solo qualora la Terra attraversi tale regione conoidale
risulta altamente probabile un'eventuale ricezione del segnale radio. Il modello fisico in grado di descrivere le
interazioni elettromagnetiche tra Giove e Io e, piu' in generale, il meccanismo
gioviano di emissione, e' in grado, come si e' detto, di fornire adeguate
previsioni di eventi radio futuri sulla base dei fenomeni sopra
descritti.
La possibilita' di ricezione di
eventuali eventi gioviani dipende strettamente da tre parametri fisici,
introdotti dagli scienziati in seguito ad una adeguata formulazione del
meccanismo di emissione:
-CMD system III: (Central
Meridian Longitude, cioe' longitudine del meridiano centrale) noto anche con il
termine di Lambda III, indica la longitudine che il meridiano centrale di
riferimento sulla superficie di Giove assume nei confronti della Terra.
L'attributo III si riferisce alla variazione che intercorre tra la rotazione del
pianeta Giove, dal quale dipende l'effettiva longitudine gioviana, e la
rotazione della magnetosfera, inclinata di 9.6 gradi rispetto all'asse del pianeta
gigante. Poiche' i fenomeni di emissione sono strettamente correlati al campo
elettromagnetico piu' che alla posizione assunta da Giove nel suo moto di
rotazione, e' stato elaborato un parametro Lambda III riferito alla misura della
rotazione del campo magnetico rispetto ai precedenti parametri CMD I e CMD II
(riferiti alla longitudine di un dato punto sulla superficie gioviana
sulla base della latitudine assunta da questo, equatoriale o a medie
latitudini).
- Io Phase: tale parametro
descrive la posizione del satellite Io rispetto alla congiungente Terra-Giove ;
posta come origine del riferimento la posizione assunta da Io in congiunzione
superiore, la fase di Io si misura in gradi sulla base del movimento rotatorio
orario proprio del satellite stesso. Fu l'apparente dipendenza tra manifestarsi
dei fenomeni radio e Io, osservata in seguito all'analisi dei dati raccolti, a
suggerire per la prima volta un possibile nesso tra la luna galileiana e il
pianeta Giove.
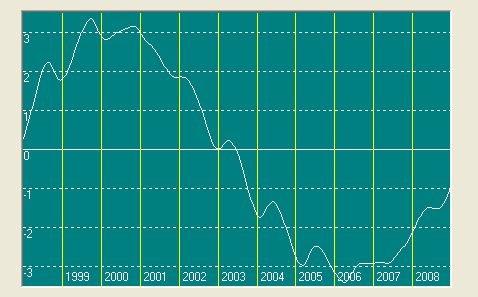 -Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo
radiativo (il quale dipende
esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'
che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo
periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di
rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale
radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante
software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del
parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato
il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro
De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta
essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato
calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza
alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione
giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con
periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.
-Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo
radiativo (il quale dipende
esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'
che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo
periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di
rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale
radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante
software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del
parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato
il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro
De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta
essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato
calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza
alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione
giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con
periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.
Come si e' detto solo i parametri CMD
III e Io-Phase risultano effettivamente correlati alla possibilita' di ricezione
del segnale radio gioviano, dal momento che essi sono intimamente correlati al
meccanismo radiativo di emissione. Piu' precisamete in un diagramma xOy avente in
ascissa il valore del parametro Lambda III e in ordinata la Io-Phase e' possibile
individuare tre aree principali di attivita' gioviana; qualora il pianeta assuma
parametri tali da risultare incluso in una di queste zone, la probabilita' di
ricezione del segnale si rivela considerevolmente maggiore. Sotto un'immagine di
tale diagramma, noto come diagramma di Bigg (dal nome dello scienziato E.K.Bigg
che nel 1964 propose, in un articolo apparso su Nature, un possibile nesso tra la
posizione di Io e l'emissione gioviana). L'immagine e' stata elaborata col
software Radio Jupiter Pro 3.
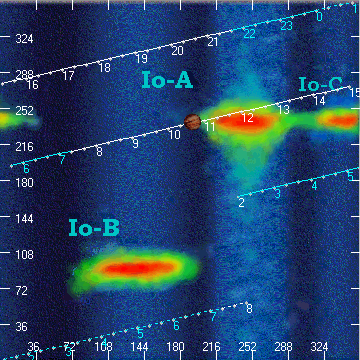
Nello specifico e' possibile
individuare tre regioni di maggior attivita' denominate rispettivamente Io-A,
Io-B e Io-C; il termine Io si richiama ovviamente alla dipendenza di tali
emissioni dalla posizione del satellite intorno a Giove, mentre le lettere sono
state introdotte al fine di differenziare le diverse zone probabilistiche di
attivita'. La regione Io-A risulta essere quella a maggiore probabilita' di
ricezione, ma non per questo va trascurata l'importanza dei restanti due
indicatori dell'attivita' radio gioviana. Accanto alle tre maggiori e' possibile
inoltre individuare la regione di probabilita' denominata Io-D. La tabella
sottostante indica l'estensione di tali aree di probabilita' in funzione dei
parametri CMD III e Io-Phase cosi' come proposti nel grafico di Bigg.
| MODE |
CML RANGE |
Io RANGE |
| Io-D |
0-200 |
95-130 |
| Io-B |
(105 - 185) |
(80-110) |
| non Io-B |
80-200 |
0-360 |
| Io-A |
(200-270) |
(205-260) |
| non-Io-A |
(230-280) |
0-360 |
| Io-C |
(300-20) |
(225-260) |
| non-Io-C |
300-360 |
0-360 |
Va infine ricordato come i segnali
radio gioviani si classifichino in due grandi gruppi, sulla base del modo con
cui essi si osservano: da un lato troviamo gli S-Burst (Short Burst), segnali ad
ampio spettro caratterizzati da una durata dell'ordine di frazioni di secondo e
una rapida deriva in frequenza; dall'altro gli L-Burst (Long Burst), anch'essi
distribuiti su un ampio range di frequenze, ma dalla durata decisamente
superiore rispetto ai primi.
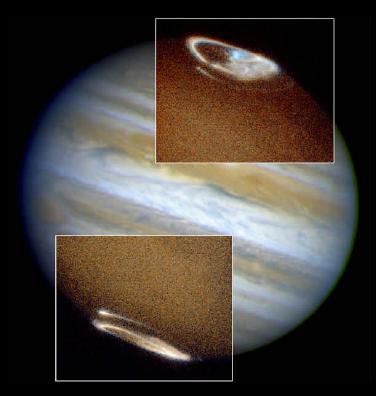 La scoperta delle emissioni radio del pianeta Giove risale al
1955, anno in cui Bernard Burke e Kenneth Franklin, entrambi al Carnegie
Institute in Washington D.C. , rilevarono in 17 delle 33 registrazioni di prova
realizzate mediante il nuovo dipolo Mills Cross Array disturbi alla frequenza di
22.2 MHz; Tali disturbi, in origine associati a fenomeni di natura
interferenziale, si dimostrarono in seguito connessi all'attivita' del pianeta
Giove. La prima ipotesi descritta non era infatti in grado di spiegare la
regolarita' con la quale questi fenomeni si manifestavano.
La scoperta delle emissioni radio del pianeta Giove risale al
1955, anno in cui Bernard Burke e Kenneth Franklin, entrambi al Carnegie
Institute in Washington D.C. , rilevarono in 17 delle 33 registrazioni di prova
realizzate mediante il nuovo dipolo Mills Cross Array disturbi alla frequenza di
22.2 MHz; Tali disturbi, in origine associati a fenomeni di natura
interferenziale, si dimostrarono in seguito connessi all'attivita' del pianeta
Giove. La prima ipotesi descritta non era infatti in grado di spiegare la
regolarita' con la quale questi fenomeni si manifestavano.
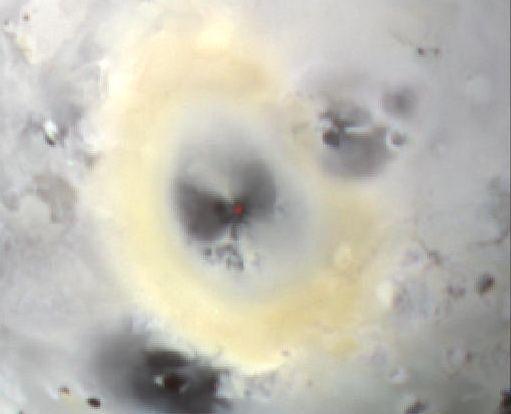
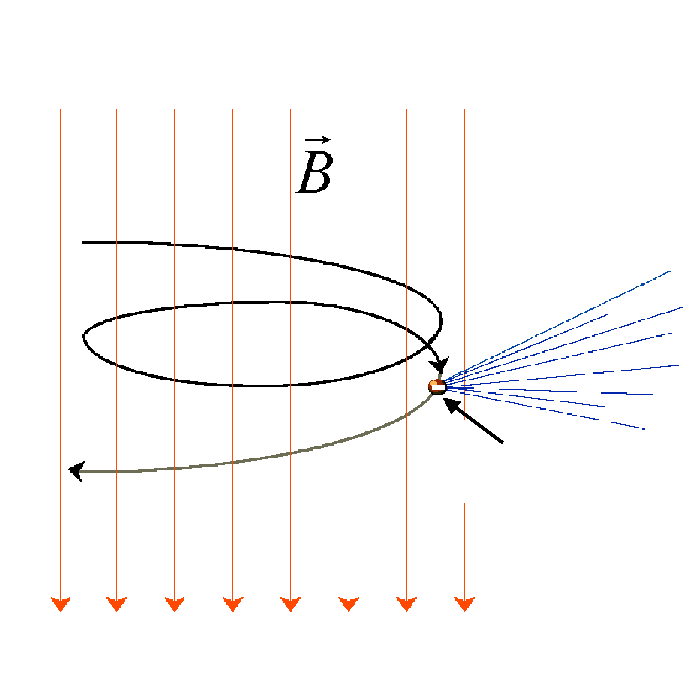 Il meccanismo di emissione e' un processo non
termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la
radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad
esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno
di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto
accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della
componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la
velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne
causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi
particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde
elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di
energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La
differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone
risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone
quand' essa assume valori relativistici.
Il meccanismo di emissione e' un processo non
termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la
radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad
esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno
di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto
accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della
componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la
velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne
causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi
particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde
elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di
energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La
differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone
risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone
quand' essa assume valori relativistici. 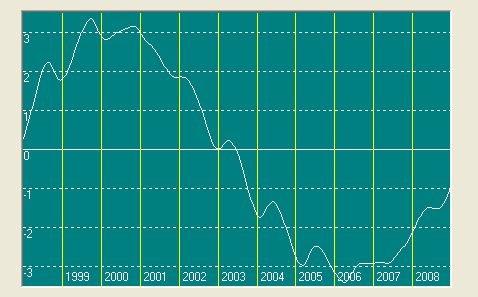 -Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo
radiativo (il quale dipende
esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'
che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo
periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di
rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale
radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante
software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del
parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato
il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro
De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta
essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato
calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza
alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione
giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con
periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.
-Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo
radiativo (il quale dipende
esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'
che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo
periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di
rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale
radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante
software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del
parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato
il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro
De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta
essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato
calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza
alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione
giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con
periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.