Esso si compone di un'antenna tipo doppio dipolo, un ricevitore e un computer. Il segnale radio emesso da Giove viene raccolto attraverso il dipolo e da qui inviato tramite cavo coassiale al ricevitore. Precisiamo in questa sede come la scelta della tipologia di antenna non sia casuale, ma risponda a precise esigenze tecniche permettendo di fatto l'esclusione dall'apparato di ricezione di eventuali motori di inseguimento di norma necessari a mantenere il radiotelescopio costantemente orientato nella direzione della sorgente; l'impiego di differenti tipi di antenna rispetto al dipolo da noi scelto (strumento tecnico questo che piu' si avvicina al modello ideale di antenna isotropa) limiterebbe di fatto il periodo di osservazione di Giove ai soli istanti in cui il pianeta, nel suo moto diurno, viene a trovarsi all'interno del ristretto lobo di ricezione del radiotelescopio, con conseguente diminuzione della probabilita' di ricezione del segnale stesso.
Giunto al ricevitore il segnale radio viene convertito in segnale audio; quest'ultimo viene quindi prelevato dal ricevitore e indirizzato alla SoundBlaster di un Personal Computer; opportuni programmi in esso installati permetteranno infine l'acquisizione ed una successiva analisi dei dati.
Predisposto un adeguato apparato di ricezione, resta ora da chiarire a quali frequenze e' preferibile sintonizzare il proprio ricevitore qualora si desideri procedere al monitoraggio dell'attivita' gioviana in banda radio.
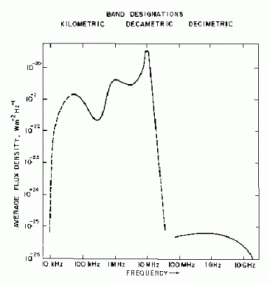 |
|
Figura 1.3. Intensita' del segnale in funzione della frequenza |
|
L'intensita' del flusso radio espressa in funzione della frequenza del segnale e' rappresentata in figura 1.3. Si nota come per una stazione di rilevamento dislocata al suolo le emissioni decametriche gioviane si distribuiscano lungo un range di frequenze indicativamente compreso tra i 5 - 10 MHz, frequenza critica al di sotto della quale si ha assorbimento del segnale da parte della ionosfera terrestre, e i 39.5 MHz, valore questo dipendente dal meccanismo radiativo. Quest'ultimo, oggi descritto in termini di emissione di ciclotrone, fornisce radiazione la cui frequenza massima consentita e' intimamente correlata all'intensita di campo magnetico alla sorgente. Al valore finito di tale intensita' corrisponde dunque un valore ugualmente finito delle frequenza massima di emissione.
Sebbene il grafico individui un picco di intensita' alla frequenza di circa 8 MHz , risulta preferibile lavorare intorno a frequenze intermedie intorno ai 18 - 26 MHz, evitando nel contempo sia eventuali influenze della ionosfera (maggiori per lunghezze d'onda maggiori) quanto il rischio di una mancata ricezione del segnale, la cui intensita' decresce rapidamente all'aumento della frequenza.
Il ricevitore da noi impiegato, proveniente dal kit di montaggio che la NASA, nell'ambito del progetto Radio Jove, mette a disposizione degli interessati, lavora, in modalita' di ricezione AM, alla frequenza di circa 20.1 MHz
Come pianificare le sessioni osservative.
Il complesso processo radiativo mediante cui Giove irradia onde elettromagnetiche di lunghezze d'onda decametriche nello spazio e' gia' stato descritto, almeno nei suoi tratti fondamentali, nel precedente Le emissioni decametriche gioviane: cause ed osservazione. Alcuni richiami si rendono tuttavia qui necessari al fine di una maggiore chiarezza espositiva. La probabilita' di osservare evento gioviani dipende fortemente dal valore assunto da tre parametri:

Central Meridian Longitude Sistem III (CMD III)
indica la longitudine che il meridiano centrale di riferimento sulla superficie di Giove assume nei confronti della Terra. Riferito al moto rotatorio della magnetosfera gioviana (come specificato dall'attributo III) varia tra 0 e 360 gradi in un periodo T = 09h 55m 71s.

Io Phase, indice della configurazione geometrica assunta dal satellite omonimo rispetto al riferimento Terra - Giove, viene definito come lo spostamento angolare della luna galileiana rispetto alla congiunzione geocentrica superiore, misurato nel senso di rotazione della stessa. Varia anch'esso tra 0 e 360 gradi in un periodo di circa 42 ore.

Jovicentric Declination of the Earth (De), definito come la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove.Il suo valore oscilla tra -3.3 e +3.3 gradi ogni 11 anni.
| Figura 1.4.
Ipotetica configurazione Terra - Giove - Io con corrispondenti valori di CMD III ed Io - Phase
|
Nella nostra indagine supponiamo costante il valore del parametro De, il quale interviene nel definire la qualita' del segnale ricevuto unicamente su periodi di osservazione molto lunghi e una cui variazione risulta comunque apprezzabile solamente mediante registrazioni di elevata precisione sperimentale. In tal modo e' possibile prevedere il manifestarsi di eventi gioviani futuri esclusivamente attraverso lo studio dell'andamento dei parametri CMD System III e Io Phase.
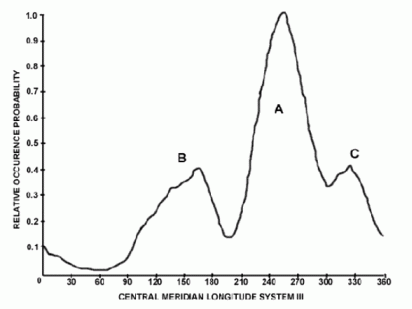 |
| Figura 1.5 |
|
Dalla comparazione tra il valore assunto dal parametro CMD System III e l'eventuale manifestarsi di eventi radio gioviani, si e' visto sperimentalmente come la probabilita' di captare il segnale di Giove aumenti considerevolmente per determinati valori di Lambda III. Piu' precisamente, dato un riferimento xOy avente per ascissa i valori di CMD III (espressi in gradi e frazioni di grado) e in ordinata la probabilita' del verificarsi di un evento gioviano (espressa in frazioni decimali) e' possibile individuare tre diverse regioni ad elevata possibilita' di ricezione, denominate rispettivamente A, B e C (vedi figura 1.5).
Era il 1964 quando sulla rivista Nature apparve un articolo di E. K. Bigg nel quale per la prima volta si ipotizzava un collegamento tra il verificarsi della tempeste di Giove con la posizione del satellite Io. Dall'analisi dei dati raccolti nel biennio
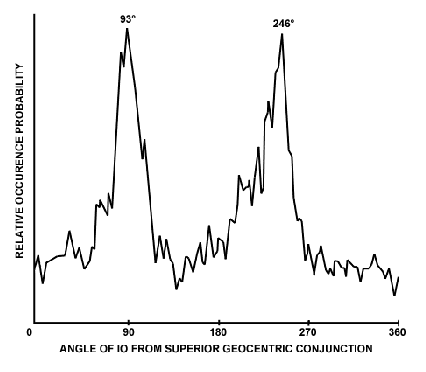
|
| Figura 1.6
|
|
1961 - 1963 Burke era riuscito a elaborare un diagramma in cui la probabilita' di ascoltare Giove veniva espressa in funzione della posizione assunta da Io. Esprimendo quest'ultima in termini di spostamento dalla congiunzione geocentrica superiore (SGC), possiamo realizzare un secondo diagramma avente in ascissa il valore di Io Phase e in ordinata la probabilita' di ricezone del segnale di Giove. Il risultato e' un grafico come quello qui proposto a lato; in esso si distinguono chiaramente due massimi che la curva individua per valori di Io Phase di 93 e 246 gradi.
Futuri sviluppi del modello di emissione gioviana permetteranno di giustificare questa osservazione sperimentale;
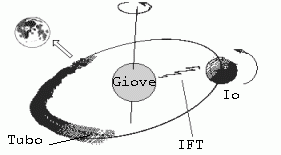
|
| Figura 1.7 |
|
gia' si e' visto infatti come la presenza di cariche elettriche nei prodotti delle eruzioni vulcaniche di Io, la maggiore velocita' di rotazione della magnetosfera gioviana rispetto alla velocita' angolare della luna di Giove, nonche' altri fattori qui non esplicitamente citati determinino lo sviluppo di scariche elettriche tra Io e l'atmosfera gioviana lungo il cosidetto tubo di flusso (Figura 1.7).
Per meglio procedere nella nostra indagine, introduciamo un nuovo strumento teorico noto come diagramma di Bigg . Esso si ottiene dalla combinazione dei precedenti grafici ponendo in un riferimento cartesiano in ascissa il valore del parametro CMD III (espresso in gradi e frazioni di grado) ed in ordinata la Io Phase (anch'essa espressa in gradi e frazioni di grado). Il prodotto di una tale combinazione fornisce il grafico sperimentale riprodotto in figura 1.8. Alle tinte blu-violetto corrisponde una maggiore probabilita' di ricezione del segnale gioviano.
|
Figura 1.8. Diagramma di Biggs |
|
In esso e' possibile individuare tre regioni ad elevata probabilita' di ricezione denominate rispettivamente Io-A, Io-B e Io-C. Da quanto fin qui espresso risulta allora evidente come la probabilita' di successo di un ascolto di Giove aumenti considerevolmente quando il pianeta viene ad assumere una di queste tre configurazioni. Una precisazione si rende qui necessaria: il fatto che in un determinato istante di tempo Giove venga a cadere all'interno di una di queste aree di probabilita' non e' condizione sufficiente a garantiere la ricezione dei segnali gioviani; qualora si decida tuttavia di procedere ad una osservazione del sistema gioviano risulta preferibile attivare l'apparato di ricezione durante il verificarsi di una delle sopra citate configurazioni.
Resta tuttavia un problema da risolvere: come determinare i parametri CMD III e Io Phase? Due le vie piu' brevi per conseguire con successo un tale scopo: ricerca in internet di tabelle di predizione o uso di opportuni software. Chi desidera optare per la seconda alternativa puo' servirsi del Radio Jupiter Pro III, distribuito a pagamento dall'agenzia spaziale americana nell'ambito del progetto Radio-Jove (al sito www.radiosky.com e' possibile scaricare una versione shareware di prova utilizzabile per 30 giorni). Per quanto concerne la prima via, oltre al gia' citato RadioSky (che alla sezione Jupiter propone un elenco con i migliori periodi di osservazione), e' possibile servirsi delle Prediction Tables che Leonard Garcia annulmente realizza e mette liberamente a disposizione degli interessati al sito dellUniversity of Florida Radio Observatory (UFRO). Sempre al sito UFRO e' possibile consultare in remoto un programma interattivo messo a punto dal professor Kazumasa Imai.
Una volta venuti in possesso di adeguate tabelle di predizione, resta tuttavia da prendere in considerazione una serie di fattori di importanza altrettanto cruciale nel programmare future serate di osservazione. Cercheremo di meglio chiarire questo punto nel prossimo paragrafo.
Quando osservare?
|
The University of Florida Radio Observatory |
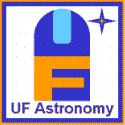
Nel sito dell'UFRO e' possibile reperire una vasta mole di notizie, informazioni e strumenti per procedere nell'osservazione del sistema gioviano; in particolar modo:  Prediction Tables
 Dispense teoriche in lingua inglese;

Suoni di emissioni gioviane
|
Supponiamo per esempio di voler osservare Giove la sera del 10 marzo 2004; procediamo nel consultare le prediction tables per tale data (di cui riportiamo una sezione in tabella 1.1):
UT | LamIII |
Io | Storm | Prob18 | Prob26 |
20 | 128. | 216. |
B |
0.0 | 0.1 |
|
22 |
201. |
233. |
Io-A |
0.1 |
0.2 | |
|
23 |
237. |
241. |
Io-A |
0.1 |
0.7 |
Tabella 1.1: Prediction Tables 10 Marzo 2004 |
|
In essa troviamo il tempo, espresso in ore di Tempo Universale (UT), i parametri CMD III (lamIII) e Io - Phase (Io), il tipo di tempesta prevista e la probabilita' di ricezione del segnale alle frequenze rispettivamente di 18 (Prob18) e 26.3MHz (Prob26). Queste ultime sono state elaborate sulla base di osservazioni sperimentali condotte presso l'Universita' della Florida; la sostanziale differenza tra i valori di Prob18 e Prob26 non ha nulla a che fare con i meccanismi radiativi gioviani e non deve scoraggiare coloro che desiderano seguire il fenomeno Giove a frequenze prossime ai 18MHz. Se in un dato istante di tempo t la configurazione della sorgente e' (λIII; Io), la probabilita' che una stazione al suolo rilevi emissioni radio gioviane ad una certa frequenza f e':
Prob(λIII; Io) ≡ H (λIII; Io) / n (λIII; Io)
dove n (λIII; Io) rappresenta il numero totale di osservazioni condotte sulla sorgente gioviana in condizioni (λIII; Io) e H (λIII; Io) il numero di eventi rilevati in tali n (λIII; Io) osservazioni. In particolare, come lo stesso Leonard Garcia specifica nella sua Jupiter Prediction Tables Documentation, il valore Prob18 e' stato calcolato facendo riferimento alle osservazioni condotte tra il 1985 e il 1992 mediante una anatenna Yagi e' il Prob26 attraverso l'analisi dei dati raccolti da 640 dipoli (operanti a 26.3 MHz) tra il 1973 e il 1981.
Consultando la tabella 1.1 potremo a buon diritto affermare come la serata osservativa da noi scelta sia particolarmente adatta per procedere all'ascolto di Giove. In realta' come gia' accennato, e' necessario tenere a mente alcuni ottimi consigli prima di intraprendere una qualunque sessione osservativa. Supponiamo di voler proceder al monitoraggio dell'attivita' radio gioviana del 10 marzo attraverso l'apparato di ricezione dell'AFAM (latitudine φ = 46 05' 11'' e longitudine λ = 13 18' 59''); alle ore 23 UT Giove si trovera', rispetto ad esso, ad un'altezza sull'orizzonte h = 51.8 gradi in direzione Sud, una posizione sufficiente a consentire una adeguata possibilita' di ricezione anche attraverso il nostro semplice dipolo. Ma che dire di un eventuale osservatore che si trovi nello stesso momento in territorio statunitense, a Los Angeles per esempio? Per questi non solo il sole splende alto nel cielo, ma Giove non risulta neppure al di sopra dell'orizzonte. E quindi opportuno rifarsi ad effemeridi astronomiche (reperibili su riviste di astronomia, tradizionali almanacchi astronomici, siti internet specializzati nonche' in versione fai-da-te su planetari virtuali), prima di incappare nel rischio di veder sfumare il vostro possibile ascolto di Giove per non visibilita' della sorgente.
Anche ammesso di poter contare su una discreta probabilita' di ricezione del segnale, nonche' su buone condizioni di osservabilita' del pianeta, i problemi non sono finiti; i tempi di ascolto vanno infatti scelti in maniera tale da ridurre al minimo l'effetto di disturbo esterno. Discriminare un evento gioviano da semplici interferenze ambientali e' infatti una delle questioni che rendono difficile lo studio in banda radio del sistema gioviano. Una semplice scarica elettrica, l'accensione di un cirquito, un fulmine in una giornata di temporale sono disturbi diffusi a larga banda che bene si prestano a mascherare il suono di Giove o a trarre in inganno anche il piu' preparato ascoltatore. Per questa ragione consigliamo sempre il salvataggio nel PC del file audio completo della registrazione, piu' che altri diagrammi intensita' del segnale - tempo , esteticamente di effetto ma di scarsa utilita' ai fini di una indagine scientifica. La corretta individuazione degli eventi gioviani e' il passo fondamentale e determinante di tutta l'operazione di analisi dei dati; compiuta questa si puo' eventualmente procedere ad un piu' approfondito esame della registrazione.
E' sconsigliata l'osservazione di Giove in ore diurne, da un lato per la presenza del Sole, potente sorgente di radiazione elettromagnetica , dall'altro per l'azione della ionosfera. La ionosfera rappresenta il secondo motivo di preoccupazione per le vostre osservazioni determinando di fatto l'assorbimento di radiazione a bassa frequenza. Come gia' detto, la frequenza critica viene di norma a dipendere dal valore della densita' elettronica, valore questo che subisce un discreto incremento nelle ore diurne ad opera dei raggi ultravioletti solari. Esperimenti condotti attraverso l'apparato ricevente dell'AFAM hanno inoltre dimostrato come in ore diurne sia maggiore la captazione di emittenti radio il cui effetto di mascheramento dei deboli segnali gioviani presumiano risulti evdente. Di notte un tale problema si riduce notevolmente venedo a mancare tutta quella gamma di segnali diffusi durante il giorno dagli strati della ionosfera. Durante il periodo estivo, quando ad un maggiore apporto di radiazione solare ultravioletta corrisponde un incremento della densita' elettronica (e quindi della frequenza critica da questa dipendente), la ionosfera puo' restare attiva anche in ore notturne, ostacolando di fatto l'attivita' di monitoraggio del pianeta gigante; tale ragione, unita alla frequenza di temporali diffusi in tale parte dell'anno (e una cui azione non solo nuoce ad eventuali osservazioni, ma puo' causare seri danni anche alle apparecchiature sperimentali) spinge molti radioastrofili a prediligere la stagione invernale per contemplare questo curioso oggetto celeste.
Detto tutto cio', non resta che armarsi di tanta pazienza e perseveranza, e nella speranza che possiate fare buon uso dei nostri consigli, attendiamo che il pianeta gigante faccia sentire la propria voce.
| A cura di Alessandro e Giuseppe Candolini |
| Gennaio 2004 |